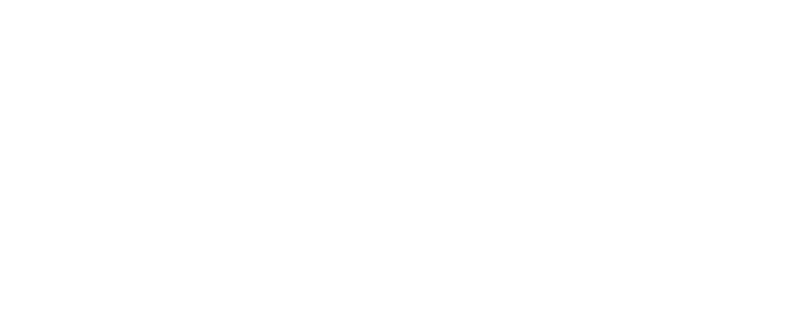Nel contesto del dibattito globale sulla tassazione dell’economia digitale, l’Italia si è distinta per il suo ruolo attivo nel promuovere la necessità di una distribuzione più equa del prelievo fiscale tra le giurisdizioni. In termini di provvedimenti interni, questa spinta si è tradotta anche in taluni tentativi di intervento, come l’introduzione- con la legge di bilancio del 2018- di una particolare estensione della nozione di “stabile organizzazione” all’interno dell’articolo 162, co.2, lettera f) bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La modifica ha mirato a includere tra le ipotesi di stabile organizzazione anche una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”, col chiaro intento di intercettare e tassare il valore generato in Italia da imprese che operano digitalmente, senza una sede fisica tradizionale; tale previsione è stata comunemente definita l’introduzione della “stabile organizzazione virtuale” nel nostro ordinamento.
Tuttavia, il caso italiano si è rivelato emblematico delle sfide interpretative e applicative che la digitalizzazione pone dinnanzi al diritto tributario. La critica principale rivolta a questa definizione è che essa, a ben guardare, sembrerebbe non distaccarsi realmente dal concetto di materialità: i requisiti imposti dal legislatore italiano per la stabile organizzazione virtuale includono infatti non solo una presenza economica significativa e continuativa, ma anche un elemento di artificiosità della sua costruzione. Questo implica che l’assenza di una consistenza fisica sia frutto di una simulazione o di un intento elusivo; agli occhi di alcuni, quasi fraudolento.
Questo approccio si discosta notevolmente dalla direzione intrapresa a livello internazionale e dell’Unione Europea. Organismi come l’OCSE e la Commissione Europea, infatti, intendono orientarsi piuttosto verso la “presenza digitale significativa” come criterio per l’imposizione, che mira a tassare la creazione di valore in un territorio indipendentemente dalla fisicità, ma senza connotare tale assenza come artificiosa o ambigua. La libertà di stabilimento, un principio fondamentale del diritto europeo, permette alle imprese di scegliere la sede più vantaggiosa dal punto di vista fiscale, e ciò non può essere di per sé considerato un abuso.
La legislazione italiana, non avendo nemmeno derogato al criterio generale della sede fissa di affari, ha creato secondo alcuni una vera e propria contraddizione interna, rendendo la nozione di stabile organizzazione virtuale potenzialmente inconsistente e più simile a una “stabile organizzazione simulata”. Questo importante profilo di ambiguità evidenzia come il legame tra la collocazione strumentale dell’impresa e il comportamento abusivo rappresenti ancora un ostacolo difficile da superare nella formulazione di un concetto di stabile organizzazione che prescinda dalla presenza fisica.
In definitiva, il tentativo italiano, pur lodevole nell’intenzione di anticipare i tempi, ha finito per mostrare le difficoltà di adeguare principi e strumenti concepiti per una realtà tipicamente materiale alla nuova virtualità. La questione rimane aperta e richiede sforzi ermeneutici e negoziali che vadano oltre la forzatura di categorie esistenti.
Elenco delle fonti utilizzate:
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) (aggiornato al 17/06/2025).
Biondi Elisabetta La sfida del diritto fiscale globalizzato: la tassazione dell’economia digitale. Tra ricerca del consenso internazionale ed esercizio della sovranità la nuova era della fiscalità internazionale è già iniziata, 07 mar. 2025, Iris LUISS, https://dx.doi.org/10.13119/11385_249020.
Del Federico Lorenzo, Il sistema tributario e l’economia digitale, in Del Federico Lorenzo, Paparella Franco, Diritto tributario digitale, Pisa, 2023, pp. 43-54.