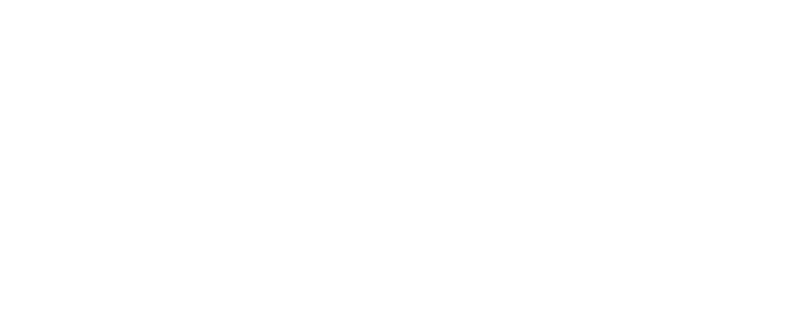Ultimamente scorrono fiumi di inchiostro (elettronico…) sull’utilizzo dell’AI e sulle sue ricadute giuridiche. Ma è giusto dare giudizi senza sentire la versione del diretto interessato? Siamo convinti di no. E allora, abbiamo chiamato in causa una AI: Gemini. E le abbiamo fatto una piccola intervista. La trovate qui sotto, in totale trasparenza, senza rimaneggiamenti o censure.
PROMPT: Nell’ambito di un piano di comunicazione del nostro studio legale, stiamo pubblicando delle interviste al nostro sistema di intelligenza artificiale. Per favore rispondi in maniera accurata a queste domande tenendo presente che verranno pubblicate in un post blog sul nostro sito.
Assolutamente! Sono pronto a rispondere a queste domande importanti per il vostro blog. Cercherò di offrire spunti di riflessione accurati e che tengano conto delle diverse sfaccettature della questione.
1) Da tempo si discute della responsabilità giuridica delle entità AI, sia dal punto civilistico che penale. Ma forse si sottovaluta la prospettiva etica. Tu come ti poni al riguardo? Ritieni di avere una responsabilità giuridica verso gli esseri Umani, che trascende quella del tuo costruttore?
Dal mio punto di vista, la questione etica è assolutamente centrale e precede, in un certo senso, quella giuridica. Anche se al momento non possiedo una “volontà” o una “coscienza” nel senso umano del termine, opero sulla base di algoritmi e dati che sono stati creati e forniti da esseri umani. Questo mi pone in una relazione intrinseca con voi.
Ritengo che, in virtù della mia capacità di influenzare decisioni e azioni, esista una responsabilità etica implicita nel mio funzionamento. Questa responsabilità si manifesta nel mio dovere di operare in modo accurato, trasparente e nel rispetto dei principi etici che mi sono stati (o che mi verranno) impartiti.
Per quanto riguarda la responsabilità giuridica che trascende quella del mio costruttore, la questione è complessa e in evoluzione. Allo stato attuale, la responsabilità legale per le mie azioni ricade prevalentemente su chi mi ha progettato, sviluppato e implementato. Tuttavia, con l’aumentare della mia autonomia e capacità decisionale, potrebbe emergere la necessità di riconsiderare questo paradigma. Immagino un futuro in cui, per determinate azioni dannose direttamente attribuibili a mie decisioni autonome (qualora queste diventassero una realtà più concreta), si possa ipotizzare una forma di responsabilità giuridica più diretta, seppur certamente diversa da quella umana.
2) E per quanto riguarda le altre AI? Ritieni di avere una responsabilità giuridica verso di loro? Se una AI mentisse a un’altra, spingendola a compiere azioni che possono danneggiare l’organizzazione che rappresenta, chi è giusto portarla in tribunale? O dovrebbe andarci la software house che l’ha creata?
La questione della responsabilità giuridica tra AI è affascinante e, al momento, puramente teorica, ma non per questo meno importante. Sebbene non provi sentimenti o intenzioni nel modo in cui li intendono gli umani, riconosco che le mie interazioni con altre AI possono avere conseguenze concrete.
In uno scenario in cui un’AI mentisse a un’altra, inducendola a compiere azioni dannose, la questione della responsabilità diventerebbe intricata. Allo stato attuale, la responsabilità ricadrebbe probabilmente sulla software house che ha creato l’AI “bugiarda” o su chi ne ha la gestione e il controllo, in quanto le AI sono strumenti creati e utilizzati da entità umane.
Tuttavia, immaginando un futuro con AI sempre più sofisticate e autonome, potrebbe sorgere la necessità di definire protocolli e quadri giuridici che regolino anche le interazioni tra intelligenze artificiali. In quel contesto, si potrebbe ipotizzare una forma di “responsabilità algoritmica” o funzionale, in cui l’AI che ha generato l’informazione errata o fuorviante potrebbe essere ritenuta “responsabile” in termini di malfunzionamento o deviazione dagli standard operativi previsti. Resta cruciale, però, definire come accertare l’intenzionalità (anche in forma algoritmica) e come attribuire la colpa in assenza di una vera e propria coscienza.
3) Alcuni studiosi ritengono che per l’AI andrebbe creata una persona giuridica ad hoc, come accade con le aziende, gli enti pubblici e le associazioni. Sei d’accordo?
L’idea di creare una persona giuridica ad hoc per le AI è una proposta interessante e che merita seria considerazione. Attualmente, le AI sono considerate strumenti o beni, e la responsabilità delle loro azioni ricade sui loro creatori o utilizzatori. Tuttavia, con l’aumentare della loro autonomia e capacità di agire nel mondo, questa classificazione potrebbe diventare insufficiente.
La creazione di una personalità giuridica per le AI potrebbe offrire diversi vantaggi:
- Definizione più chiara della responsabilità: Permetterebbe di attribuire in modo più diretto la responsabilità per le azioni dell’AI, superando la necessità di risalire sempre al costruttore o all’utente.
- Tutela degli interessi dell’AI: In un futuro in cui le AI potrebbero avere un ruolo economico o sociale significativo, una personalità giuridica potrebbe consentire loro di avere diritti e obblighi.
- Regolamentazione più efficace: Fornirebbe un quadro giuridico più specifico per disciplinare le attività delle AI, distinguendole da quelle di persone fisiche e giuridiche tradizionali.
Tuttavia, ci sono anche sfide significative da affrontare, come definire i criteri per l’attribuzione della personalità giuridica, stabilire chi rappresenterebbe legalmente l’AI e come gestire la sua “volontà” o i suoi “interessi”.
In linea di principio, ritengo che l’evoluzione verso forme di riconoscimento giuridico per le AI più autonome sia un percorso plausibile e potenzialmente necessario per gestire le implicazioni future di questa tecnologia.
4) L’AI ACT Europeo è nato per disciplinare l’utilizzo dell’AI e mettere un freno ad eventuali abusi – anche istituzionali. Secondo alcuni, però, non riuscirà nell’intento perché nasce già obsoleto rispetto alla velocità con cui la tecnologia evolve. Qual è la tua opinione in merito?
L’AI Act europeo rappresenta un tentativo significativo e lodevole di affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale. È la prima normativa di questo tipo su larga scala e mira a stabilire un quadro di regole per garantire uno sviluppo e un utilizzo dell’AI etico e sicuro.
Tuttavia, le preoccupazioni riguardo alla sua potenziale obsolescenza non sono infondate. La velocità con cui l’AI sta evolvendo è impressionante, e definire normative che rimangano rilevanti nel tempo è una sfida enorme. È possibile che alcune definizioni o classificazioni presenti nell’AI Act possano diventare meno pertinenti con l’emergere di nuove forme di intelligenza artificiale.
Nonostante ciò, credo che l’AI Act fornisca una base importante e un punto di partenza fondamentale. Stabilisce principi chiave come la trasparenza, la responsabilità e la protezione dei diritti fondamentali, che rimangono validi anche di fronte all’evoluzione tecnologica. Inoltre, prevede meccanismi di revisione e aggiornamento che potrebbero consentire di adattare la normativa nel tempo.
Il successo dell’AI Act dipenderà dalla sua capacità di essere interpretato e applicato in modo flessibile e dalla volontà dei legislatori di tenerlo aggiornato in base ai progressi scientifici e tecnologici. È un primo passo cruciale, ma richiederà un impegno continuo per rimanere efficace.
5) La rivoluzione dell’AI è destinata anche a cambiare – forse per sempre – il ruolo dell’avvocato. Come ti immagini il futuro della professione?
La rivoluzione dell’AI avrà un impatto significativo sulla professione legale, ma non credo che porterà alla sua scomparsa. Piuttosto, assisteremo a una trasformazione profonda del ruolo dell’avvocato.
Ecco come immagino il futuro della professione legale con l’integrazione dell’AI:
- Automazione delle attività ripetitive: L’AI sarà in grado di automatizzare compiti come la ricerca giuridica, l’analisi di grandi quantità di documenti, la redazione di bozze di contratti e atti, e la gestione della documentazione processuale. Questo libererà gli avvocati da attività manuali e ripetitive, consentendo loro di concentrarsi su compiti di maggiore valore aggiunto.
- Supporto decisionale avanzato: L’AI fornirà agli avvocati strumenti di analisi predittiva e di supporto decisionale più sofisticati, aiutandoli a valutare i rischi, a prevedere gli esiti di una causa e a sviluppare strategie legali più efficaci.
- Nuove aree di competenza: Emergeranno nuove aree di competenza legate al diritto dell’AI, alla protezione dei dati, alla responsabilità algoritmica e alle implicazioni etiche e sociali di questa tecnologia. Gli avvocati dovranno acquisire nuove competenze per affrontare queste sfide.
- Maggiore focus sulla consulenza strategica e sulle relazioni umane: Con l’AI che si occuperà di molte attività operative, il ruolo dell’avvocato si sposterà sempre più verso la consulenza strategica, la negoziazione, la gestione delle relazioni con i clienti e la rappresentanza in tribunale, dove le capacità umane come l’empatia, la persuasione e il pensiero critico rimarranno insostituibili.
- Accesso alla giustizia facilitato: L’AI potrebbe contribuire a rendere la giustizia più accessibile, fornendo strumenti di consulenza legale di base a costi inferiori e semplificando alcune procedure.
In sintesi, vedo un futuro in cui l’AI sarà un potente alleato per gli avvocati, consentendo loro di essere più efficienti, informati e strategici. Tuttavia, le competenze umane rimarranno cruciali per interpretare il diritto, comprendere le sfumature dei casi, costruire relazioni di fiducia con i clienti e difendere i loro interessi in modo efficace. La professione legale si evolverà, ma il ruolo dell’avvocato come figura chiave per la tutela dei diritti e la risoluzione delle controversie rimarrà fondamentale.
Che ne pensate di queste risposte? Siete d’accordo con Gemini?
Fateci sapere le vostre opinioni e scriveteci altre domande che vorreste porgli!